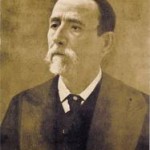domenica 4 maggio 2025
“Presso il quinto termine lapideo dalla linea del litorale salernitano si erge un monte, circondato su ambo i versanti da colli boscosi, che per via di un’apertura a guisa di finestra sulla cima, è chiamato dagli abitanti del luogo “Monte Finestra“. Separa il territorio dei tramontini da quello dei cavesi. Dove le (sue) falde sono rivolte al sole orientale, al livello in cui il pendio va a rimpianare, c’è un’enorme cavità, che gli antichi chiamavano (Grotta) Arsiccia, da cui Cava prese il nome. Dall’antichità Cava è conosciuta anche con il nome di Valle Metelliana; ciò da quando si tramanda che vi si fosse stanziata la gens romana dei Metelli. Bagna la valle un fiumicello di nome Selano che, scorrendovi in mezzo con un soave mormorio, si getta nel vicino golfo di Vietri. Invero, specialmente per i villeggianti d’estate, l’aspetto del luogo è così ameno, che non esiste niente di meglio. Vi è una vallecola esposta contro lo zefiro (a est), seminata con erbette profumate e fragole, che assieme mitigano l’arsura e accarezzano alti fiorellini con i ruscelli del Selano. Ci vive un rarissimo colubro (biscia) e nessun animale ostile all’uomo; e i colli vicini, coperti da odorosi boschetti, risuonano giorno e notte dei concerti degli usignoli. Quando il raggio di sole, smorzato dall’ombra degli arboreti (o vite arbustiva), investe di luce tenue i pianori verdeggianti, le rive del torrente e i pendii dei rilievi, agli osservatori sembrerà di stare a Tempé tessalica…”
Le due cime del Monte Finestra (anticam. Fenestra), sono state da sempre raggiungibili senza grandi difficoltà dai rispettivi valichi a N e S. Ma al di là della frequentazione dei locali pastori, di boscaioli, cacciatori e briganti, fino a buona parte dell’800 le uniche menzioni della montagna sono su codici manoscritti che descrivono i limiti dei possedimenti e pertinenze della Badia di Cava, e su documenti d’archivio che delineano i confini comunali (Tramonti, Cava de’ Tirreni, Vietri sul Mare, Cetara e Maiori) che si dipanano lungo i crinali di M. Finestra e dei Monti del Demanio.
(dati provenienti dal sito di Francesco Raffaele).
L’itinerario di domenica ha inizio nel territorio di Tramonti, e precisamente dalla frazione di Gete. Dopo una rapida visita alla cappella rupestre di San Michele inizieremo il Sentiero delle Tramontane (Giustino Fortunato 6 bis), che all’ombra di un bosco misto ed in costante ascesa ci porterà al valico di Foce di Tramonti (m 913). Da questo punto il nostro percorso si innesta sul CAI 300, Alta Via dei Monti Lattari, e devia in direzione nord verso la cima bicefala del Monte Finestra, del quale guadagneremo prima la Vetta Sud (m 1145) e poi, dopo una sosta al buco nella roccia che da origine al toponimo di questa montagna, la Vetta Nord (m 1138).
Ampi i panorami in questo tratto sia sulla Valle di Tramonti che sulla Valle di Cava de’ Tirreni, i due comuni dei quali questa spettacolare cresta funge anche da confine. Dopo la meritata sosta pranzo ripartiremo, sempre in direzione nord, e superata la cresta di Pietrapiana lasceremo l’Alta Via poco dopo il valico di Tuoro di Sant’Angelo. Inizia qui la discesa che lungo il colle di Pizzo Falcone (m 664) ci porterà di nuovo a Tramonti, questa volta nella frazione di Campinola.
Info di Riepilogo:
| – Difficoltà: | EE – escursionistica per esperti; |
| – Dislivello: | 850 m in salita – 680 m in discesa; |
| – Distanza: | circa 10 Km.; |
| – Durata: | 5 h. escluso soste; |
Accompagnatori: Francesco Saverio Gargiulo – Salvatore Donnarumma.
Appuntamento per i peninsulari sul sagrato della chiesa di Meta ore 7:30; mentre per gli altri a Gete di Tramonti ore 8:35 – clicca qui per vedere il luogo.
La colazione sarà a sacco e munirsi di acqua per le proprie esigenze.
Rientro in serata.
La partecipazione alle escursioni è aperta a tutti i soci FIE ed, eccezionalmente, anche ai non soci e simpatizzanti utilizzando la polizza temporanea giornaliera compilando il modulo scaricabile qui, comunicando entro venerdi antecedente l’escursione entro le 12:00 le proprie generalità e codice fiscale e una quota occasionale di 10,00 € da presentare all’appuntamento.
La copertura assicurativa, in caso di infortunio riguarda SOLO i soci in regola con il versamento della quota sociale.
Ricordiamo sempre che le nostre escursioni prevedono dei tratti in pendenza e/o con tracciati sterrati, siamo in montagna e quindi munitevi sempre di scarpe adeguate da escursionismo con suole antisdrucciolo e possibilmente in goretex, abbigliamento a strati (con ricambio), altrimenti saremo costretti a farvi rinunciare alla escursione stessa.
Per garantire il rispetto degli altri partecipanti e delle tempistiche non sarà tollerato ritardo; Durante l’escursione è doveroso mantenere un comportamento rispettoso dell’ambiente e degli altri partecipanti;
Le escursioni ULYXES, coerentemente con la loro natura, pongono i partecipanti di fronte ai rischi ed ai pericoli inerenti la pratica dell’escursionismo in montagna. I partecipanti, pertanto, iscrivendosi alle escursioni giornaliere accettano tali rischi e sollevano l’associazione ULYXES, gli organizzatori e i collaboratori delle predette escursioni da qualsiasi tipo di responsabilità per incidenti ed infortuni che si dovessero verificare durante l’escursione.
L’escursione potrà essere rinviata per motivi legati alle cattive condizioni meteorologiche, previo avviso su questo stesso sito.